#Curiosità: Il Carbone
- Angela Salvitti

- 5 gen 2021
- Tempo di lettura: 5 min

Una calza della Befana a prova di monelli
“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte”
... chi non conosce questa filastrocca? E chi non rimane in attesa della calza per vedere se sarà carica di carbone o di dolcetti? Allora mi sono chiesta, ma perché proprio il carbone viene lasciato dalla simpatica nonnina ai bimbi monelli?
Facendo alcune ricerche ho trovato notizie interessanti che ho condiviso insieme ai collaboratori di ConEtica20, perché loro di carbone ne sanno parecchio! Partiamo dal principio e vediamo di conoscere più a fondo il protagonista:
Cos’è il carbone?
Da dove viene?
E perché lo troveremo nelle nostre calze?
Il carbone è un combustibile fossile così come il petrolio e il gas naturale. A differenza di questi ultimi, il carbone è un combustibile solido e tra i combustibili solidi, è il più utilizzato al mondo nella produzione di energia elettrica. Mentre il petrolio e il gas naturale si sono formati dai resti di microscopici organismi acquatici sedimentati sul fondo di antichi mari, il carbone è costituito dai resti di piante del passato le cui strutture e forme sono ancora riconoscibili al microscopio.
Il carbonio rimane il principale componente del carbone dopo che gli altri componenti fondamentali sono progressivamente venuti meno durante i processi chimico-fisici che l’hanno trasformata. La combustione del carbone libera, dunque, l’energia del Sole immagazzinata dalle piante con la fotosintesi milioni di anni fa: per questo, è un prezioso contenitore di energia solare “fossile”, ma produce anche anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio, anidride solforosa e ossidi di azoto. Andiamo nello specifico e cerchiamo di capire qualcosa di più partendo dai diversi tipi di carbone che possiamo incontrare.
La prima grande famiglia è quella dei carboni fossili naturali che comprende la Torba, che è un tipo di sostanza spugnosa (che mostra ancora i resti delle piante da cui deriva) ed è principalmente impiegata come combustibile negli altiforni e come concime nel giardinaggio. Poi c’è la lignite, composto terroso di formazione più giovane, che viene estratto nelle miniere a cielo aperto; la sua caratteristica è quella di avere una fiamma molto fumosa.
Il lintrace invece fornisce i più grandi giacimenti carboniferi del mondo ed è composto al 90% di carbonio. L’antracite, è la sorella più anziana della famiglia, è un tipo di carbone nero, duro, resistente e brucia di solito con una fiamma priva di fumo; la sua caratteristica principale è la sua capacità calorifera che varia dai 22 ai 28 milioni di Btu/ton (da 26 a 33 MJ/kg), per questo è stato il tipo di carbone maggiormente impiegato per il riscaldamento domestico.
Passiamo all’altra famiglia che è quella dei carboni non fossili che comprende il carbone vegetale, derivato dalla carbonizzazione della legna, e il carbon cooke, ottenuto invece dai processi di raffinazione del petrolio in impianti chiamati cokerie.
Andiamo ora a vedere quando,come e perché il carbone è entrato a pieno titolo nelle nostre vite. L’era del carbone inizia verso la meta’ del 1600, in seguito all’esigenza di trovare una fonte di energia alternativa al legno: il carbone fossile sembrò l’alternativa più valida a disposizione perché era presente nel sottosuolo di molti paesi del centro Europa e si prestava molto bene come fonte di energia per le prime macchine a vapore. In pochi decenni la richiesta di carbone aumentò in maniera esponenziale. A partire dal 1750, in Inghilterra prende il via la Rivoluzione industriale, che sconvolse radicalmente il sistema economico, sociale e possiamo dire energetico. La grande richiesta di carbone ha portato ad una corsa di ricerca di giacimenti, tanto che nei primi del 1900, molti uomini hanno prestato il loro servizio come minatori. L'estrazione del carbone però, storicamente, è stata un'attività estremamente pericolosa, infatti fu proprio nelle miniere di carbone che avvennero i più gravi incidenti minerari sia negli Stati Uniti d'America (Monongah, West Virginia, 6 dicembre 1907, 362 vittime) che in Europa (Disastro di Marcinelle Belgio, 8 agosto 1956, 262 morti; Courrières, Francia, 10 marzo 1907, 1099 morti). Non ci furono solo tragedie lavorative, ma anche disastrosi impatti ambientali poiché tutte le forme di industria mineraria generavano aree in cui il carbone veniva impilato (come i cumuli di carbone), che a loro volta producevano un drenaggio acido particolarmente ricco di metallo che andava a confluire nelle acque correnti. Inoltre i mucchi di scorie dei giacimenti erano soggette a scivolamenti pericolosi, come ha tristemente testimoniato il disastro di Aberfan, villaggio inglese travolto e distrutto da un cumulo, in cui morirono nel 1966, 144 persone.
Ma ora torniamo a noi e cerchiamo di capire come il carbone è passato dalle miniere alla calza della Befana! Una leggenda narra che i Re Magi non riuscendo a trovare la strada per arrivare alla capanna di Betlemme, chiesero informazioni a una vecchietta. Questa si rifiutò di aiutarli, rispondendo anche in modo un po’ sgarbato. Quando i Re Magi ripartirono, la vecchina, pentita della propria azione, per rimediare, riempì un sacco di dolci e si mise in cammino, bussando a tutte le porte alla ricerca di Gesù e offrendo ai bambini i doni che aveva portato con sé. Una tradizione più antica collega la Befana al simbolo dell’anno appena passato, un anno ormai vecchio proprio come lei. I doni che la vecchietta portava, erano dei simboli di buon auspicio per l’anno che sarebbe iniziato. Ed ecco qui che entra in scena il carbone, non solo simbolo di punizione, come metafora del fatto che comportamenti sbagliati non generano niente di buono, (ma solo qualcosa che rimane duro e nero), ma anche monito per l’avvenire. Sì, perché qualunque cosa legata al fuoco e alla combustione nella tradizione pagana simboleggiava purificazione e rinascita. Quindi la nostra cara vecchietta, con il carbone ci vuole dire non solo che siamo stati cattivi, ma soprattutto che l’anno appena iniziato può portare occasione di migliorarci e di avere comportamenti fecondi per noi e per gli altri.
E aggiungo, anche per il nostro Pianeta. Già perché le dimensioni delle riserve di carbone provate nel 2017 a livello mondiale sono circa 1.035 miliardi di tonnellate; ma al ritmo attuale di consumo, (e in assenza di nuove scoperte o della messa in esercizio dei giacimenti attualmente non sfruttati) le riserve provate di carbone dureranno per circa altri 134 anni, un tempo molto limitato.
Inoltre la combustione del carbone è considerata tra le principali fonti di emissione antropogenica di Arsenico e Mercurio, oltre che di CO2. Le ceneri leggere (fly ash) e altri rifiuti di una centrale a carbone rilascerebbero nell'area circostante una quantità di radiazioni 100 volte superiore a quella di un impianto nucleare a parità di energia prodotta.
Secondo uno studio commissionato da Greenpeace, l'impatto ambientale della combustione del carbone è indicato come responsabile di 366 morti premature ogni anno in Italia, oltre che principale fautore dell’allargamento del buco nell’ozono.
A fronte di ciò appare evidente di quanto sia importante rivolgere l’attenzione a fonti di energia pulita, rinnovabili, che non hanno una scadenza e soprattutto che non siano così inquinanti. Per questo il carbone è meglio lasciarlo usare solo alla Befana come monito per i monelli e limitare i suoi impieghi nel mondo energetico.
Così facendo sono sicura che tutti noi saremo meritevoli di poco carbone e di tanti dolcetti per aver dato una mano al nostro Pianeta!





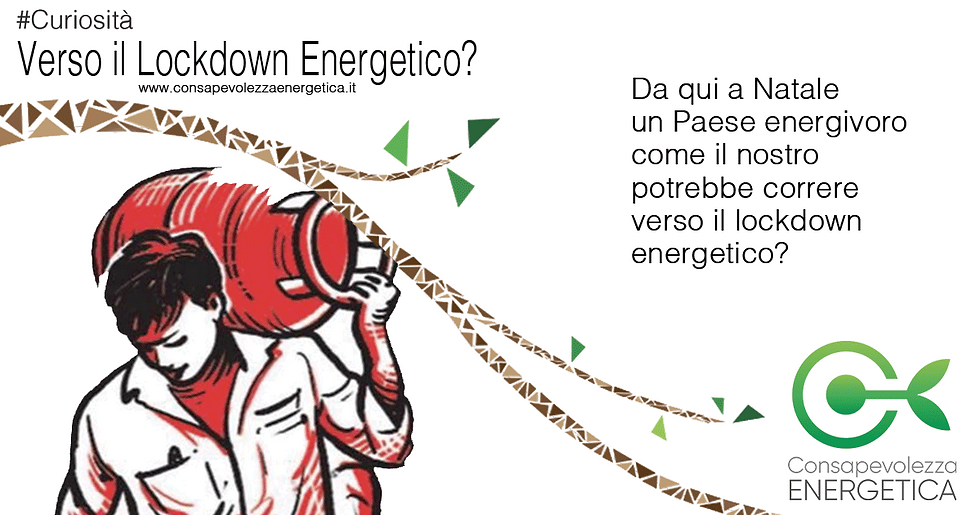

Commenti