#Curiosità: Right to Repair
- Raffaele Bruno

- 8 mag 2021
- Tempo di lettura: 3 min

Lo scorso mese ho acquistato nuovo cellulare: il motivo è che il display era rovinato (problema piuttosto frequente) ed il prezzo che avrei dovuto sostenere per ripararlo non valeva l’investimento. Considerando inoltre che non erano più disponibili aggiornamenti per la mia versione e la memoria era ormai totalmente satura, non ho potuto far altro che andare ad acquistarne uno nuovo accantonando quello vecchio.
Il cellulare aveva solo tre anni in realtà e speravo potesse avere una “vita più lunga”! Ma così non è stato e mi è venuta la curiosità di vedere cosa dicevano le statistiche riguardo la frequenza con la quale si cambiano gli ormai inseparabili smartphone.
Stando a quanto riportato dalle ultime ricerche di Ting Mobile, emerge che gli utenti, contrariamente agli anni passati, non cambiano più lo smartphone ogni due anni. Infatti il 47% dei 3000 utenti intervistati ha affermato di aver posseduto l’ultimo cellulare per un periodo che spazia dai 3 ai 5 anni.
Dato confortante considerando che la media fino a pochi anni fa era di massimo 2 anni; nonostante ciò mi è sembrato comunque assurdo dover sostituire un cellulare, in buono stato, per via della mancanza di aggiornamenti o per la mancanza di pezzi di ricambio a cifre economicamente sostenibili.
Si parla tanto di ecosostenibilità, un tema attorno al quale si crea sempre più attenzione e si discute sempre di più anche a livello internazionale, allora sorge spontaneo chiedersi se è utile al nostro pianeta avere un mercato così “di consumo” dei prodotti tecnologici.
Il diritto alla riparazione (Right to Repair) mette in luce la problematicità del fenomeno dell'obsolescenza programmata.
Per obsolescenza programmata, in economia industriale, si intende una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata in un periodo prefissato.
Il risultato è che un prodotto, nella maggior parte dei casi elettronico, è progettato in modo da diventare inutilizzabile dopo un lasso di tempo con il fine di incentivare il consumatore ad acquistarne uno nuovo, ad esempio il modello successivo, sebbene da un punto di vista funzionale cambi poco con quello precedente.
Una delle aziende che ne ha ricavato maggior profitto da questo tipo di strategia è la Apple.
Sia chiaro che la compagnia della Mela ne è solo un esempio; questi sono in realtà comportamenti standard del mondo tecnologico.
Apple ha dovuto affrontare diverse cause legali in cui è stata accusata di progettare i propri prodotti secondo questo principio.
Nel 2003 uno dei prodotti di punta della compagnia era l’iPod. Questo aveva una vita utile di circa due anni e la Compagnia non offriva batterie di ricambio. La vicenda si è conclusa con un rimborso sia ai clienti che riscontravano le batterie difettose, sia ai denunciatari che avevano dovuto affrontare le spese legali.
Senza andare così lontano, lo scorso gennaio l'associazione dei consumatori Altroconsumo ha intrapreso una causa di 60 milioni contro la compagnia a causa di un aggiornamento obbligatorio dell’IPhone che, secondo loro, ne riduceva le funzionalità ottenendo dalla Apple degli sconti nelle riparazioni.
Qualcosa fortunatamente sembra lentamente cambiare: nel 2019 infatti l'Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento, entrato in vigore quest'anno, che impone ai produttori l'obbligo di rendere disponibili pezzi di ricambio per almeno 7 anni dal momento in cui mettono in vendita un prodotto, fornendo inoltre al consumatore un manuale di istruzioni per riparare l'oggetto autonomamente.
Il fine è quello di rendere l' elettrodomestico il più longevo possibile ed evitare così sprechi non necessari.
I benefici di un sistema volto alla riparazione piuttosto che la sostituzione sono notevoli. Tra i tanti vi è sicuramente un risparmio di tempo, di denaro e soprattutto una buona dose di riduzione dell’impatto ambientale perché quel prodotto dovrà poi essere riciclato con grande consumo di energia, risorse ed emissioni.
Ma c’è un limite di questo regolamento ed è la sua applicazione: infatti solo oggetti come le lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e televisori ne beneficeranno, lasciando fuori due categorie fondamentali che rappresentano il nucleo importante del problema: computer portatili e smartphone.
I proponenti del nuovo regolamento hanno avuto un'idea simile a quella che obbliga i produttori a mostrare i livelli di consumo di un elettrodomestico per stabilire i livelli di efficienza, ovvero un punteggio che stabilisce il grado di riparabilità degli oggetti in vendita in modo che, le aziende, abbiano un incentivo a rendere i prodotti più riparabili ed incrementare la concorrenza.
Questo indice di riparabilità e un numero da 1 a 10 che indica quanto sia facile aggiustare i prodotti guasti; esso deve essere calcolato dal produttore stesso sulla base di 5 fattori:
- l'accessibilità delle istruzioni per la riparazione
- la facilità di smontaggio
- la disponibilità dei pezzi di ricambio
- il prezzo
- Fattore che varia in base alla tipologia di prodotto

L’indice sarà dato dalla media di questi 5 fattori. Tale valutazione diventerà obbligatoria dal gennaio 2022





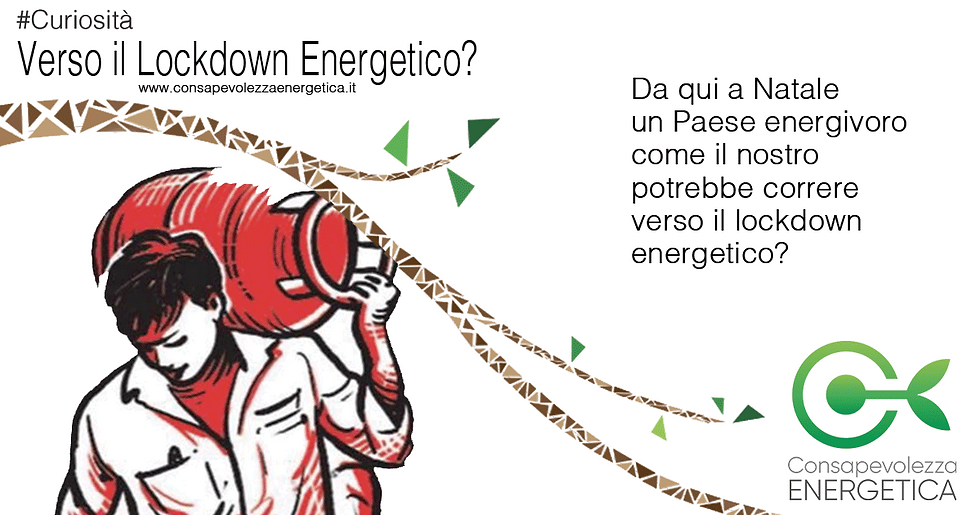

Commenti