#Curiosità: "Comunità Energetiche"
- Giovanni Pasquali

- 30 gen 2021
- Tempo di lettura: 4 min

Lo sviluppo delle “Comunità Energetiche” per una nuova consapevolezza energetica sociale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto ministeriale “Incentivi” del Ministero dello Sviluppo Economico” in attuazione dell’articolo 42-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), si completa finalmente la disciplina che rende realtà la creazione delle Comunità Energetiche in Italia.
Con il recepimento della “Direttiva RED II” viene resa finalmente possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini; i consumatori di energia elettrica potranno associarsi per realizzare configurazioni di Autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche.
Si tratta di una possibilità che non esisteva in precedenza, poiché sussisteva il limite normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo dall’utente presso il quale l’impianto era installato, e che rivoluziona il sistema energetico del nostro Paese rendendo possibile una nuova consapevolezza energetica sociale o meglio una nuova transizione energetica.
Con la pubblicazione sul Portale del GSE, in data 22 Dicembre 2020, delle regole tecniche con i requisiti necessari, le modalità di accesso, lo schema di contratto standard e le tempistiche di erogazione degli incentivi, i privati cittadini, le attività produttive ed enti pubblici possono iniziare a costituire le Comunità e usufruire dei vantaggi a esse connessi.
Vediamo in sintesi cosa sono e come funzionano.
L’articolo 21 della Direttiva sulle energie rinnovabili (n. 2001/2018 detta anche RED II) definisce l’autoconsumo collettivo realizzato all’interno di un edificio, grazie ad un sistema che fornisce elettricità a più di un consumatore ("uno a molti”). L’esempio classico è quello di un edificio multi-unità con un impianto fotovoltaico nell’area comune, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia sia per le utenze condominiali che per quelle delle unità autonome. Quando l’autoconsumo collettivo trascende l’ambito di un unico edificio o condominio, siamo di fronte ad una comunità energetica.
Difatti l’Autoconsumo collettivo può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle famiglie non producano energia come attività principale. Alle Comunità Energetiche, invece, possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, Enti Territoriali o Autorità locali, comprese le Amministrazioni comunali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello condominiale, purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell’energia di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale.
Mentre l’autoconsumo collettivo negli edifici potrà essere gestito dal proprio condominio, le comunità energetiche posso adottare la forma contrattuale di qualsiasi entità capace di agire a proprio nome e essere destinataria di obblighi e diritti. Nei due casi, la partecipazione deve essere aperta, basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Questo vuoi dire che, se il condominio installa un impianto di generazione nell’edificio, tutti i condomini interessati devono potere aderire all’autoconsumo collettivo. Allo stesso modo, in una comunità energetica in corso di creazione, tutti gli utenti interessati, afferenti alla medesima cabina elettrica di media/bassa tensione, hanno il diritto di aderire alla comunità (cooperativa/associazione/ecc.). L’adempienza agli obblighi condominiali è uno dei criteri obiettivi per l’accesso alla comunità. È anche possibile creare categorie di membri distinti tra loro, che si differenziano per il fatto di essere soci utenti (quelli che non partecipano all’investimento per l’istallazione del sistema di generazione o accumulo) e soci utenti/investitori (quelli che supportano finanziariamente l’installazione del sistema di generazione o accumulo). In entrambi i casi, gli utenti mantengono il loro fornitore di elettricità e possono uscire dallo schema di autoconsumo collettivo o della comunità energetica in qualsiasi momento. In caso di recesso anticipato, la compartecipazione agli investimenti sostenuti deve risultare equa e proporzionata.
Quello delle Comunità energetiche è un universo in grado di innescare un circolo virtuoso di vantaggi e benefici ambientali, sociali ed economici diretti, e puntare a una crescita sostenibile, abbattendo le emissioni inquinanti e riducendone le conseguenze ambientali e sanitarie, fortemente impattanti nei centri urbani.
Tra i benefici diretti riconosciuti ai membri che aderiscono alle Comunità energetiche c’è la riduzione dei costi della bolletta elettrica, un benefit che può contribuire in maniera efficace ad affrontare anche il problema della povertà energetica tra i cittadini, condizione che vede l’Italia collocarsi alla 19° posizione tra i 28 paesi membri dell’Unione europea, e nella quale vivono, secondo un’indagine realizzata dallo Spi-Cgil e dalla Fondazione Di Vittorio, poco più di nove milioni di italiani, ossia più del 15% del totale, con un impatto particolarmente rilevante per la popolazione anziana. Sfruttare questa opportunità significa individuare la giusta strategia non soltanto per raggiungere più facilmente gli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima e i target molto più sfidanti individuati dall’Unione europea per ridurre gli impatti e affrontare i rischi del cambiamento climatico, ma anche favorire concretamente la transizione energetica.
La transizione energetica, intesa come costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, è secondo noi non solo necessaria e urgente ma anche indifferibile. Perché diventi tangibile ed effettiva, dovranno essere innescati cambiamenti culturali, materiali ed immateriali, basati sul risparmio energetico e l’efficienza dei consumi. In un tale scenario, l’attivazione di nuove forme di azione collettiva e di economie collaborative (in cui produzione e consumo danno vita a nuovi sistemi di scambio), unite alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, costituiranno i punti cardine della transizione energetica, oltre a rappresentare un’opportunità per la creazione di nuovi modelli di green economy. Se la transizione energetica è necessaria in termini di sostenibilità ambientale, essa non potrà pienamente realizzarsi senza una gestione congiunta di problemi ambientali, sociali ed economici che utilizzi un approccio co-evolutivo e interattivo, data l’inseparabilità e l’influenza reciproca del cambiamento sociale e tecnologico. Una transizione energetica richiede cambiamenti culturali, materiali ed immateriali, basati sul risparmio energetico e l’efficienza dei consumi. Si pone dunque un importante quesito che ci riguarda da vicino, avendo al centro delle nostre discussioni e azioni il concetto di comunità.
“Come possiamo ripensare oggi l’essere in comune? Come vivere insieme?”
Il quesito è una provocazione per riflettere sulle possibilità di convivenza con l’altro e con l’ambiente, sulla complessità del “vivere con” in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Riconoscersi in una comunità è il primo passo da compiere in direzione un’etica di coabitazione pacifica con gli uomini e l’ambiente.





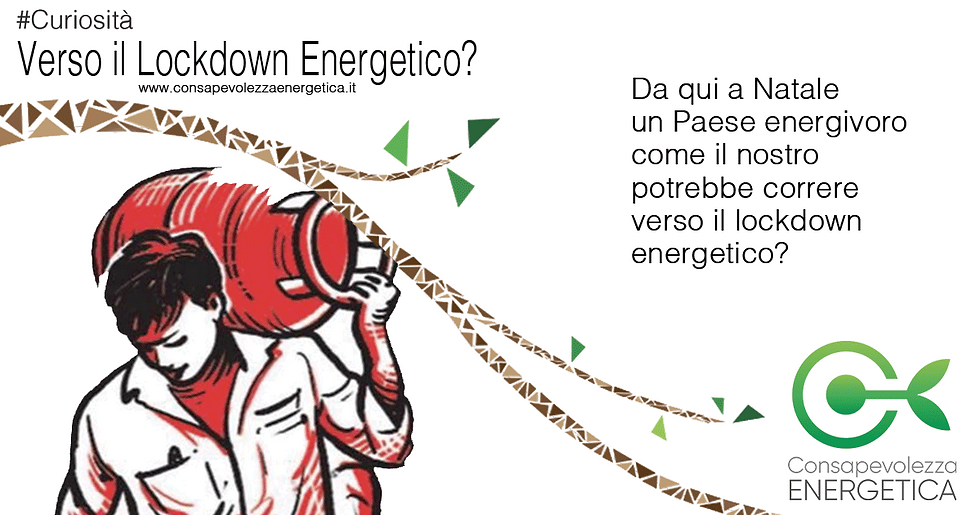

Commenti